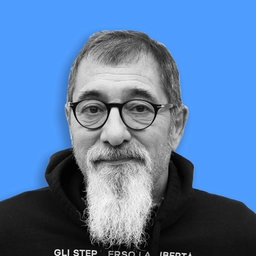Il museo etnologico del Mulino Colombo conserva 25mila oggetti fotografati e catalogati di cui 400 relativi alla vita domestica
Mulini nascosti nel verde della Brianza, ma anche ben in vista in pieno centro città. È il caso del Mulino Colombo, a Monza, in vicolo scuole 11, a ridosso dell’Ufficio di igiene, un monumento di archeologia industriale nel salotto buono della città. Qui venivano macinati i semi di lino, per lavorazioni industriali e consumo domestico. I 31 mulini dell’alto Lambro sono stati oggetto di un’indagine e pubblicazione curata dal Museo etnologico di Monza e Brianza, finito di stampare nel 1997, sotto la presidenza dell’architetta Anna Sorteni.
La pubblicazione è stata offerta al capogruppo della Lega Alessandro Corbetta ieri, in visita al mulino con la collega Alessandra Cappellari, prima firmataria del progetto di legge regionale per il recupero dei mulini storici. "La signora Antonietta Colombo – narra Anna Sorteni nel volume – ha donato il mulino di famiglia al Comune, nel 1987, che lo ha restaurato e messo a disposizione della Brianza". Il Mulino è in gestione al Museo etnologico, che lo apre al pubblico 10 ore la settimana con due mostre all’anno. Attualmente ospita la mostra “La casa di un tempo: utensili e memorie“. L’esposizione rievoca gli oggetti della vita quotidiana di un tempo, in diretta dalle case dei nostri nonni. L’ambiente dal sapore antico ben si presta ad ospitare bilance a bracci, scatole di latta decorate, macinini per il caffè, zangole per il burro e una splendida ghiacciaia, antenato in legno e zinco del moderno frigorifero. "Il museo etnologico conserva 25mila oggetti (fotografati e catalogati), di cui 400 relativi alla vita domestica – spiega il presidente Alberto Naboni – tra i quali sono stati selezionati 170 suggestivi utensili e oggetti domestici, valutati e puliti ad hoc". Il Mulino Colombo, chiamato Mulino di San Gerardino, era costituito da due corpi staccati, costruiti longitudinalmente al corso del fiume che in quel punto era diviso in tre rami. Nello spazio interno tra i due corpi erano inserite le ruote, come si rileva dalla pianta del 1772 di Giovanni Filippini. Il documento più antico, datato 1807, ricorda i proprietari originari: nell’ala destra del fabbricato la famiglia Bonsaglio e a sinistra le sorelle Pagnoni.
La ruota in pietra detta “molazza“ riporta l’inizio della lavorazione dell’olio, nel 1871. Ma prima, visto che nella zona abitava la famiglia di San Gerardo dei tintori, si ipotizza che tutti i mulini della zona si occupassero della follatura, cioè la battitura della lana per renderla compatta e della tintura. Solo nel 1910 la proprietà passò a Giuseppe Colombo che vi si trasferì con la sua famiglia, già composta da sei figli. Qui ne nacquero gli altri sette e tutti si occuparono del frantoio dei semi di lino. L’edificio ha subito diverse ristrutturazioni con l’intenzione di ripristinare le macchine e le murature, ma senza perdere il fascino originale della penombra e lo spessore quasi tattile dell’aria che conserva ancora l’atmosfera greve e untuosa delle lavorazioni dei secoli passati.
Con qualche imprevisto. L’elettrificazione del Mulino Colombo risale al 1936, ma il quadro elettrico, come fanno notare i volontari del Museo etnologico che lo gestiscono, si trova all’interno dell’Ufficio igiene. Spesso con le piogge salta la corrente e per ripristinarla occorre entrare nell’Ufficio che però nei fine settimana, proprio quando vengono i visitatori, resta chiuso. Perciò non di rado il museo del Mulino Colombo resta al buio.
L’impianto è inoltre collegato alle paratie del Lambro: quando l’acqua abbonda e vanno modulate le paratie, nel mulino non arriva corrente. Il problema è stato più volte segnalato all’assessorato alla Cultura e all’Ufficio lavori pubblici.
C.B.