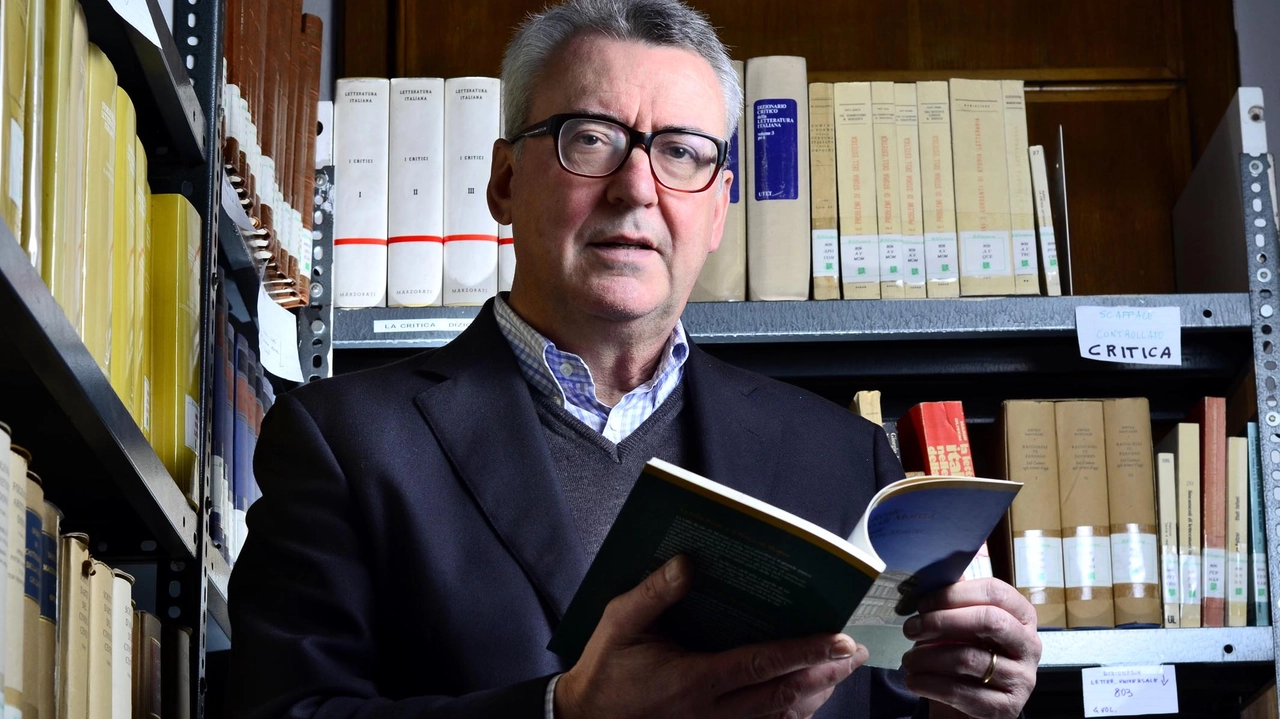
Lo storico Domenico Flavio Ronzoni
Seregno (Monza e Brianza), 15 maggio 2016 - Insegna (anche) storia, al prestigioso Collegio Ballerini di Seregno. Ha scritto una trentina di libri e decine di articoli di giornale in questo settore, è stato direttore del periodico Brianze ed è il coordinatore editoriale per Bellavite Editore. Stiamo parlando dello storico Domenico Flavio Ronzoni (moglie e due figli), nato il 25 maggio 1956 a Carate, cresciuto a Briosco, di cui è stato anche sindaco negli anni Ottanta, figlio di un operaio e di una casalinga. E soprattutto, appunto, storico di vaglia, considerato uno dei maggiori esperti per quanto riguarda la Brianza e gli eventi che l’hanno contrassegnata e costruita, soprattutto nel corso degli ultimi due secoli. Anche se quando il suo percorso nel mondo della ricerca storica è cominciato, è stato con una laurea in storia medioevale con una tesi su un arcivescovo pisano vissuto nel XII secolo.
Historia magistra vitae, come dicevano gli antichi: la storia è maestra di vita? "Una bella frase, citata anche troppo spesso... perché è vera solo se si sa riflettere sulla storia e ricavare qualche indicazione utile da quanto accaduto, ma - è triste riconoscerlo - questo in realtà capita raramente".
Proviamo allora con un’altra frase fatta... “la storia la scrivono i vincitori”? "È sempre stato così: già Tacito, in piena epoca romana, anche se era innovativo, si trovava pur sempre dalla parte dei vincitori. Bisogna riconoscere però che nel Novecento è maturata una considerazione diversa, con attenzione anche alla cosiddetta piccola storia. Quella legata alla vita quotidiana della gente...".
Gli storici mentono? "A volte sì, la storiografia è piena di ricostruzioni volutamente di parte... restando nel nostro Paese, le pagine più drammatiche e lancinanti della storia italiana del Novecento sono segnate da storie, controstorie, revisionismi in cui ha pesato parecchio l’appartenenza ideologica e politica. Basti considerare cosa è successo a chi si è permesso di parlare della Resistenza come di una guerra civile, come ad esempio ha fatto negli ultimi anni il giornalista Giampaolo Pansa".
Perché è diventato uno storico? "Finché andavo al liceo, in realtà la storia per me era una noia mortale... la mia passione è nata piuttosto all’università (la Cattolica di Milano, ndr) frequentando le lezioni di storia medioevale di monsignor Piero Zerbi. È nata così la mia passione per la ricerca e ho iniziato a frequentare gli archivi milanesi, un vero tesoro: tanto è vero che ho iniziato ad applicare le mie ricerche alla storia del mio paese. E a sei anni di distanza dalla laurea, ho COSì pubblicato il mio primo libro, dedicato a Briosco nel 1898".
Cosa scoprì? "Erano gli anni delle rivolte per il pane a Milano, delle cannonate di Bava Beccaris sulla gente che protestava per le strade. E anche Briosco ebbe le sua parte: un grande proprietario terriero dell’epoca minacciò il licenziamento di cinquanta lavoratori iscritti a...".
Il partito socialista? "No, il Comitato Parrocchiale! Erano guidati da un parroco molto battagliero... da lì mi interessai sempre più agli aspetti sociali di Ottocento e Novecento e nel 1994 scrissi un libro sul passaggio dell’economia brianzola dai campi alla fabbrica. Poi mi trovai a coordinare un gruppo di lavoro sulla storia di Carate Brianza. Insomma, mi sono appassionato molto alla fase fra Ottocento e Novecento".
Si è occupato molto di Brianza... come si può definire il suo popolo? "Il cosiddetto popolo della Brianza è storicamente caratterizzato da due elementi. Prima di tutto, è stato profondamente segnato dalla controriforma cattolica, a partire da San Carlo la tendenza del popolo brianzolo risente dell’organizzazione delle parrocchie e dell’influenza dei parroci, che anno dopo anno compilavano addirittura un libro di quanto accadeva, il Chronicon, dove annotavano persino se uno andava o meno a messa, se faceva la comunione alla domenica o se leggeva il Corriere della Sera! Il secondo tratto caratteristico dei Brianzoli è la cultura del lavoro, che in fondo discendeva anche da un senso del dovere quasi religioso che derivava dall’influenza delle parrocchie e che si sta un po’ perdendo nelle ultime due generazioni".
I Brianzoli passano poi per essere dei gran taccagni... "Non è esatto, direi piuttosto che si trattava all’epoca di gente molto accorta, piuttosto che avara. Capace di grandi gesti di generosità ma anche abituata, come si diceva in dialetto, a drizzà i ciot, insomma a recuperare anche i chiodi per un nuovo utilizzo...".
Con occhio da storico, il nostro è il migliore dei mondi possibili? O abbiamo vissuto epoche migliori? "Mi chiedono a volte se ho nostalgia per il mondo passato... Non posso dire però che un tempo si stesse meglio, la generazione di mio padre ad esempio non aveva in casa l’acqua corrente: mi piace però guardare al passato perché mi sembra giusto far conoscere come si era soprattutto alle nuove generazioni, che non hanno più una dimensione del tempo e del passato e vivono sempre nel presente. Mentre ricordare da dove veniamo e a prezzo di quali sacrifici, significa molto».
Sempre con spirito critico, però... «La ricchezza dei Brianzoli, di cui nell’immaginario comune si parla da decenni, discende da un’epoca in cui nei settori del tessile, del legno piuttosto che, a Monza soprattutto, dei cappellifici, migliaia di operai erano sottopagati e vivevano in condizioni morali e igienico sanitarie molto critiche. Bisogna però anche sapere che molta industria è nata proprio da operai che guardavano avanti e si inventavano nuove soluzioni produttive con quello che era definito un tempo spirito di intrapresa".
È cambiato molto nel frattempo... "E ci sono aspetti che rischiano di essere trascurati e dimenticati: la famiglia ad esempio era un elemento importante in quel processo che ha generato i Brianzoli di oggi ma si tratta di un istituto che, piaccia o meno, ha subito uno sconquasso considerevole negli ultimi cinquant’anni".
Uno storico sogna mai di avere a disposizione una macchina del tempo e poter andare a scandagliare un’epoca del passato? "Certo... ma se avessi una macchina del tempo a disposizione non vorrei viaggiare però poi tanto lontano, mi basterebbe andare nel secondo Dopoguerra: mi sarebbe piaciuto condividere quella voglia di novità e di costruire il nuovo che si respirava dopo l’ultimo conflitto mondiale... mi incuriosisce, l’Italia di oggi in fondo è nata da lì".
Come storico, qual è la scoperta di cui va maggiormente fiero? "Aver gettato una luce su personaggi dimenticati come Ernesto Teodoro Moneta, a tutt’oggi unico premio Nobel per la Pace italiano (nel 1907). Nel 1997 gli ho dedicato un libro: fu una figura notevole, a tratti anche contraddittoria, era stato del Risorgimento e aveva combattuto, eppure era diventato un uomo di pace e un grande giornalista dando vita a pubblicazioni che erano diventate punto di riferimento mondiale per la pace, uno dei primi a parlare di Stati Uniti Europei".
E poi? "Partendo sempre dalla mia terra, ho raccontato la figura di quello che ho ribattezzato il Papa Alpinista, Achille Roncalli, il futuro Pio XI... un vero appassionato e frequentatore della montagna, ben prima delle celebri sciate di Karol Wojtyla".
Dove andremo a finire? Gli storici possono prevederlo? "Anche se quello dello storico è spesso un lavoro oscuro, a volte la ricerca storica aiuta a capire non soltanto il passato, ma può anche indicare quale traccia di sviluppo può avere il futuro".
La felicità per lo storico Domenico Flavio Ronzoni? "Scoprire qualcosa di nuovo, trovare un documento che apra uno spiraglio di novità su un’epoca o permetta di aggiungere qualcosa che non si conosceva".

