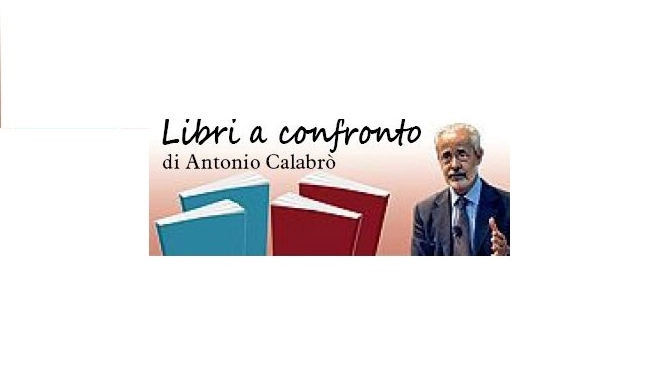
Libri a confronto di Antonio Calabrò
Milano, 3 gennaio 2016 - PAROLE d’autore. Di Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Fernanda Pivano. L’esperienza e il racconto. La realtà e la finzione. Vivere e scrivere, con tutti i conflitti che l’anima creativa scatena. Ce ne sono ampie tracce nelle lettere che Moravia scrive dal 1926 al 1940, raccolte in un volume curato da Alessandra Grandelis per Bompiani, “Se è questa la giovinezza vorrei che passasse presto”. Sono gli anni dell’esordio letterario con “Gli indifferenti” (definito dai critici più attenti “il primo romanzo italiano del XX secolo” e letto da Pietro Pancrazi, sofisticato letterato, con continui accostamenti a Freud e a Joyce), delle amicizie e dei tempestosi amori con donne dalla forte tempra intellettuale, dei confronti politici che si scontrano con la ruvida censura del fascismo.
Moravia ne scrive a lungo, in carteggi sinceri con Umberto Morra (cui è stato segnalato dai suoi cugini Rosselli), Bernard Berenson, Curzio Malaparte, Nicola Chiaromonte, Carlo Levi, Mario Pannunzio, Giuseppe Prezzolini e altri ancora. E parla di viaggi e incontri, di passioni e inquietudini, di cinema, teatro e letteratura, di tensioni politiche che maturano in ambienti fortemente segnati dal liberalismo di Piero Gobetti e poi da una più netta inclinazione a sinistra. Nelle lettere, si percepisce con nettezza il formarsi di un mondo di idee e valori che poi caratterizzeranno il Moravia grande scrittore, con una robusta capacità critica, curiosa, ironica. Passa in modo fecondo, quella giovinezza delle cui tempeste sono dense le lettere.
Già, occorre andare alle radici della formazione e dei primi forti conflitti, per entrare nel cuore dei grandi artisti. Come fa Anna Tonelli, storica attenta e scrupolosa, in “Per indegnità morale”, ricostruendo per Laterza “il caso Pasolini nell’Italia del buon costume”. È il 1949 quando Pasolini viene espulso dal Pci per “indegnità morale”. La sua omosessualità fa scandalo. La politica e più in generale la società sono condizionate dalle “due chiese”, quella cattolica e quella comunista, impegnate a orientare morale e custumi degli italiani. E per gli “eretici” alla Pasolini non c’è spazio. Ma Pasolini non si arrende, non si nasconde, non si adegua. Tutta la sua vita d’autore, tra romanzi, film, teatro, saggistica, è orientata dalla ricerca, sinceramente vissuta, di una profonda dimensione di verità umana. Che incontra successi artistici. Ma continua a sollevare scandalo e suscitare scabrose polemiche.
Sino all’assassinio, all’Idroscalo di Ostia, nel 1975. Sui cui misteri, ancora aperti, indaga David Grieco, amico e collaboratore dell’artista, con “La macchinazione – Pasolini, la verità sulla morte”, Rizzoli. “Un sordido delitto”, dice Grieco, su cui le indagini si sono “limitate alla manovalanza”, lasciando in ombra le caratteristiche di “delitto politico complesso”. Su cui ricominciare a riflettere. Rileggendo e rivedendo anche l’insieme delle opere di Pasolini, la tormentata ricerca di autenticità, libertà, controversa verità.
È il mestiere dello scrittore, d’altronde, lavorare sull’umanità e la verità. Lo testimonia Fernanda Pivano, di cui Bompiani pubblica un testo sino a oggi inedito, “Lo zio Tom è morto”, un racconto sul “cuore nero degli Stati Uniti”, sugli schiavi di colore, la loro musica, le rivolte, le battaglie contro la discriminazione razziale, l’intelligenza creativa. Grande americanista, la Pivano. Scrittrice e traduttrice cui dobbiamo la conoscenza di molte pagine della migliore letteratura Usa. Questo saggio ne conferma lo spessore intellettuale e civile.

