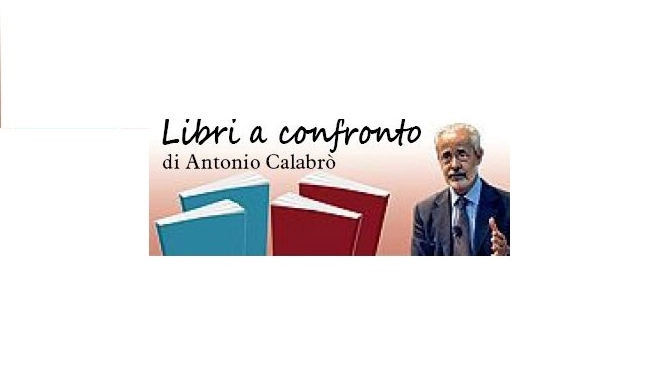
Libri a confronto di Antonio Calabrò
Milano, 27 novembre 2016 - “Mi chiamo Pepe Carvalho e sto cucinando una coscia d’agnello da latte alla birra…”. Movimenti in cucina, rimescolando lo stufato. Sguardo verso la libreria, in cerca d’un volume con cui accendere il camino. Ed ecco di nuovo in scena il famoso detective, protagonista dei romanzi di Mánuel Vasquez Montalbán, di cui Feltrinelli manda in libreria una raccolta di racconti, “Carvalho indaga”, sapidi come un piatto di baccalà o un vino, di cui appunto il detective fa abbondante uso. Il piacere del testo e delle pietanze. E quell’agnello da latte ben cucinato, con cui si apre il monologo conclusivo di Pepe (gli umori, le passioni, le preoccupazioni dell’invecchiare, le emozioni del controverso rapporto tra autore e personaggio, letteratura e vita) può fare da simbolo della centralità del cibo, nella nostra quotidianità ma anche nel nostro immaginario. Essere, insomma, “Il sugo della storia”, per dirla con il titolo del nuovo libro di Massimo Montanari, Laterza, che parte dalla conclusione de “I Promessi sposi”, “il sugo della storia”, appunto (non la morale, ma il meccanismo generatore del significato) per dire che “anche in cucina il sugo è quello che dà senso e identità a un piatto”, pasta o riso, carne o pesce che sia. Cibo e cucina, dunque. Valori sociali, rituali, simbolici: “Il panettone non è solo un composto di farina burro zucchero eccetera, ma anche un ‘segno’ del Natale”. Eccoci dunque in pagine in cui si parla di spaghetti al pomodoro (origini arabe, industria in Sicilia, condimento derivato da un ortaggio arrivato dal Sud America) e “spaghetti alla bolognese” (sconosciuti a Bologna, ma deriva internazionale delle tradizionali tagliatelle), lasagne, insalate.
La cucina, le tradizioni cui non indulgere troppo (“Ciò che chiamiamo tradizione non è altro che una invenzione ben riuscita”), l’appetito (dal latino ad-petere) e cioè l’essere attratti e seguire il piacere, “rielaborando in senso culturale l’istinto della fame”. E poi la convivialità, il rapporto mutevole tra gusto e buongusto e la cultura, a cominciare da “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, il libro che nel 1891 “fonda” la grande cucina italiana. Sono temi ricorrenti pure nelle pagine di “La passione del gusto” di Rosalia Cavalieri, Il Mulino, ovvero “quando il cibo diventa piacere”. Si parte da Aristotele, che teorizzava “il vivere bene” e parlava dei cuochi come “produttori professionisti di piacere”, si attraversa il Medioevo che mette “la gola” tra i sette vizi capitali e si arriva ai nostri tempi, in cui s’indaga sui rapporti tra cibo ed eros, sulle dimensioni conviviali e sulle “nuove frontiere della passione alimentare” e gli interessi dell’industria. Sino al fenomeno del food porn, la moda del fotografare il cibo e condividerne le immagini sui social network. Dal piacere all’ossessione. Il cibo va letto anche nella dimensione della storia. Come fa Francesco Antinucci in “Il potere della cucina”, Laterza, con racconti di “cuochi, re e cardinali”: Maestro Martino, nel cuore dell’Umanesimo, Bartolomeo Scappi, cuoco di tre cardinali e due papi, sino al “papa santo” Pio V che, per moralizzare Roma, avvia le crociate contro il lusso, prediligendo il sacrificio e il digiuno (destino infausto, per un culture della più raffinata cucina) e François Vatel che, nella Francia barocca di Luigi XIV, prepara pietanze squisite e si suicida per timore di non avere abbastanza pesce per un solenne banchetto in onore del “Re Sole”. Cibo, simbolo del potere. Ma anche della precarietà. E del tramonto.

