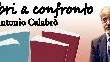
Libri a confronto
Milano, 6 marzo 2016 - Ah, Il “meraviglioso quotidiano” di cui parlava Louis Aragon. Era Parigi il suo riferimento: strade, piazze, musei, librerie, bistrot e brasserie, luoghi di ritrovo di artisti e poeti. Ma ognuno di noi c’è l’ha, il suo “meraviglioso quotidiano”, fatto d’esperienze e ricordi. E basta solo alzare lo sguardo dall’abitudine grigia per trovare, proprio nei gesti che sembrano consueti, nei volti familiari, nei paesaggi sempre visti, quel “di più” che colora diversamente il tempo dei nostri giorni. Non è un ossimoro, il “meraviglioso quotidiano”, ma l’attitudine poetica e giocosa a guardare e vivere meglio la vita. E a raccontarla. Ad Aragon, appunto, fa esplicito riferimento Marc Augé nelle pagine di “Un etnologo al Bistrot”, pubblicato da Raffaello Cortina, quando torna con la memoria ai tempi degli studi universitari, ai seminari, ai bicchieri di vino per accompagnare divertenti e colte conversazioni, ai cibi svelti, ai momenti passati in quei “luoghi che si collocherebbero da qualche parte a mezza via tra i troques più plebei e i più raffinati dei caffè”. Spazio di relazioni piacevoli. Ma anche spazio letterario: senza i bistrot non sarebbe possibile immaginare Maigret. Posto denso di vita. E rifugio solitario in cui provare a celebrare una cerimonia degli addii e dimenticare un amore infranto, un’amicizia persa. Bistrot, insomma, come luogo in cui la città rivela l’anima e alle anime inquiete rende omaggio.
Già, i luoghi dell’anima. E dei ricordi. Li percorre, con una punta di malinconia e parecchia bonaria ironia, Francesco Guccini nelle pagine di “Un matrimonio, un funerale, per non parlare del gatto”, per Mondadori. Dopo i due volumi de “Il dizionario delle cose perdute”, Guccini torna nei luoghi delle radici, i paesi dell’Appennino ai confini tra Toscana ed Emilia. E ritrova antiche abitudini, chiacchiere da bar, i giochi verbali, le voci del mercato e l’arrancare in salita della corriera, il sapore dei cibi dei giorni di festa, un tenore appassionato ciclista, un sarto spesso ubriaco, il compagno di scuola che s’inventa la morte della madre pur di non farsi interrogare. Parla di sé. E di tutti noi.
Ognuno ha un paese da cui ha provato il gusto d’andarsene via e a cui, nonostante tutto, continua a tornare, anche se soltanto con un volo di fantasia. Viaggia e racconta anche Ascanio Celestini, straordinario attore e abile scrittore, in “Un anarchico in corsia d’emergenza”, Laterza, resoconti d’avventure di persone che, della storia “abitano solo la periferia”: i labirinti delle città, le vicende femminili, lo sguardo d’un uomo sapiente che passa per matto, i ricordi della nonna, il gusto paradossale eppur verissimo delle fiabe. Anche in queste pagine, c’è il sapore dell’anima, la più segreta e sincera. Ancora un viaggio: quello di Angelo Ferracuti che, su consiglio d’un dirigente delle Poste, si mette in movimento e tra l’11 marzo e il 29 settembre del 2015, percorre un po’ tutta l’Italia, da Chamois in Valle d’Aosta a Salina nelle isole Eolie e ne fa un divertente resoconto in “Andare. Camminare. Lavorare” ovvero “l’Italia raccontata dai portalettere” per Feltrinelli. Si va nelle pieghe della provincia italiana. Così densa di straordinarie bellezze, un catalogo di diversità di lingue, abitudini, sguardi, ma anche paesaggi, lampi di luce nelle opere d’arte, colline dolci marchigiane e calanchi aspri calabresi. Bel lavoro, fare il portalettere, spiega Ferracuti: si va incontro ai desideri, alle attese, alle speranze delle persone. Almeno finché dureranno le lettere. A lungo, speriamo.
di ANTONIO CALABRO'

