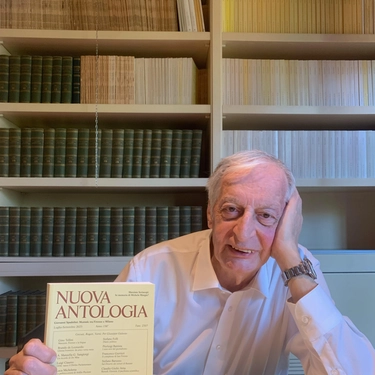La strage di Capaci
Trovate questo articolo all'interno della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata alla città di Milano. Per la prima volta i lettori potranno scegliere un prodotto completo, che offre un’informazione dettagliata, arricchita da tanti contenuti personalizzati: oltre alle notizie locali, una guida sempre aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città, consigli di lettura e molto altro. www.ilgiorno.it/
La valutazione sull’eventuale concessione di un permesso premio a un mafioso deve prescindere dal suo pentimento e deve invece concentrarsi sull’attualità o meno dei legami con la criminalità organizzata, sulla possibilità che il detenuto condannato per 416-bis possa riallacciarli e sul percorso che ha seguito in carcere. Sono le indicazioni perentorie che la Corte di Cassazione ha dato al Tribunale di Sorveglianza di Milano nell’annullare l’ordinanza che il 16 giugno 2021 ha negato per la seconda volta in un anno il beneficio a Giuseppe Barranca, 66 anni di cui gli ultimi 25 trascorsi dietro le sbarre (e fino al 2008 in regime di carcere duro al 41-bis), boss di Cosa Nostra che sta scontando nel penitenziario di Opera gli ergastoli per la strage di Capaci e per i raid dinamitardi del 1993 (dieci morti) di via dei Georgofili a Firenze, via Palestro a Milano e via del Fauro a Roma (il fallito agguato al giornalista televisivo Maurizio Costanzo).
Indagini, processi e sentenze passate in giudicato hanno inserito Barranca tra coloro che pianificarono e misero in atto l’attentato (di cui lunedì si ricorderà il trentesimo anniversario) costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie magistrato Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro: il palermitano di Brancaccio ebbe un ruolo-chiave nel reperimento dell’esplosivo piazzato sotto l’autostrada.
Dopo il primo stop al permesso premio da parte dei giudici milanesi, il 22 giugno 2020 la Suprema Corte aveva disposto un nuovo esame da parte del Tribunale di Sorveglianza, basando la sua decisione sul mutamento del quadro normativo generato dalla sentenza numero 253 del 2019 della Consulta. Una sentenza che ha dichiarato l’incompatibilità con i principi costituzionali dell’articolo 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedeva che ai detenuti condannati per associazione mafiosa (e non reclusi al 41-bis) potessero essere concessi permessi premio "anche in assenza della collaborazione con la giustizia" e pur in presenza di "elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".
Una sentenza che ha cancellato il concetto di "presunzione assoluta di pericolosità", lesivo "dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena", e rimpiazzato il parametro del "silenzio non collaborante" con quello della "persistenza del vincolo criminale". Una sentenza di cui, secondo la Suprema Corte, il Tribunale di Sorveglianza di Milano non avrebbe tenuto abbastanza conto, se è vero che il secondo provvedimento di diniego alla richiesta di Barranca avrebbe alla base "una motivazione dalla matrice spiccatamente eticizzante, che indulge in più punti a osservazioni ispirate da moralismi". Tradotto: pur sottolineando la condotta carceraria "ineccepibile" del condannato (niente rilievi disciplinari, formazione scolastica e disponibilità all’attività lavorativa) e citando la relazione datata 14 giugno 2021 in cui da Opera hanno fatto sapere che Barranca ha riconosciuto "i propri sbagli" e ha preso coscienza "del proprio passato criminale e dei reati gravissimi commessi", i giudici meneghini si sarebbero fermati "su posizioni di stigma della scelta di non collaborazione" e avrebbero orientato la loro decisione "su una valutazione “morale”" della "enorme sproporzione tra le condotte delittuose e l’appartenenza mafiosa ad altissimo livello, da un lato, e la ripresa di una vita corretta e coerente in carcere, dall’altro".
"Fuori fuoco", per gli ermellini, pure "il richiamo all’assenza di “pentimento” per il dolore provocato alle vittime dei reati" e "alla mancata presa di distanza dal fenomeno criminale che lo ha visto protagonista negativo, desunta dal fattore lessicale del mancato riferimento al termine “mafia”". Nel verdetto, si fa riferimento, in particolare, a una frase che, a parere della Cassazione, avrebbe ben poco di rilevante rispetto all’esigenza di acquisire informazioni concrete e indicative della mancanza di attualità di collegamenti con Cosa Nostra: "Non si può negare – hanno scritto i giudici della Sorveglianza – che il condannato sembra porsi sulla strada giusta, ma nel contempo questa strada va percorsa fino in fondo, uscendo dalla vaghezza del pensiero e del rammarico personale, per prendere una posizione netta e senza equivoci sui delitti commessi, sul male e sul dolore causato". Conclusione: c’è bisogno di un nuovo giudizio, che si concentri però, chiarisce ancora una volta la Suprema Corte, sulla "proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli nel futuro, in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero del detenuto, monitorata attraverso un esame a tutto campo della sua vita".